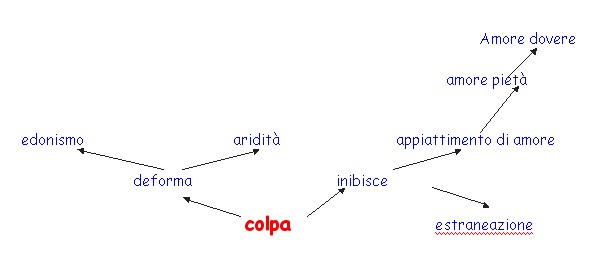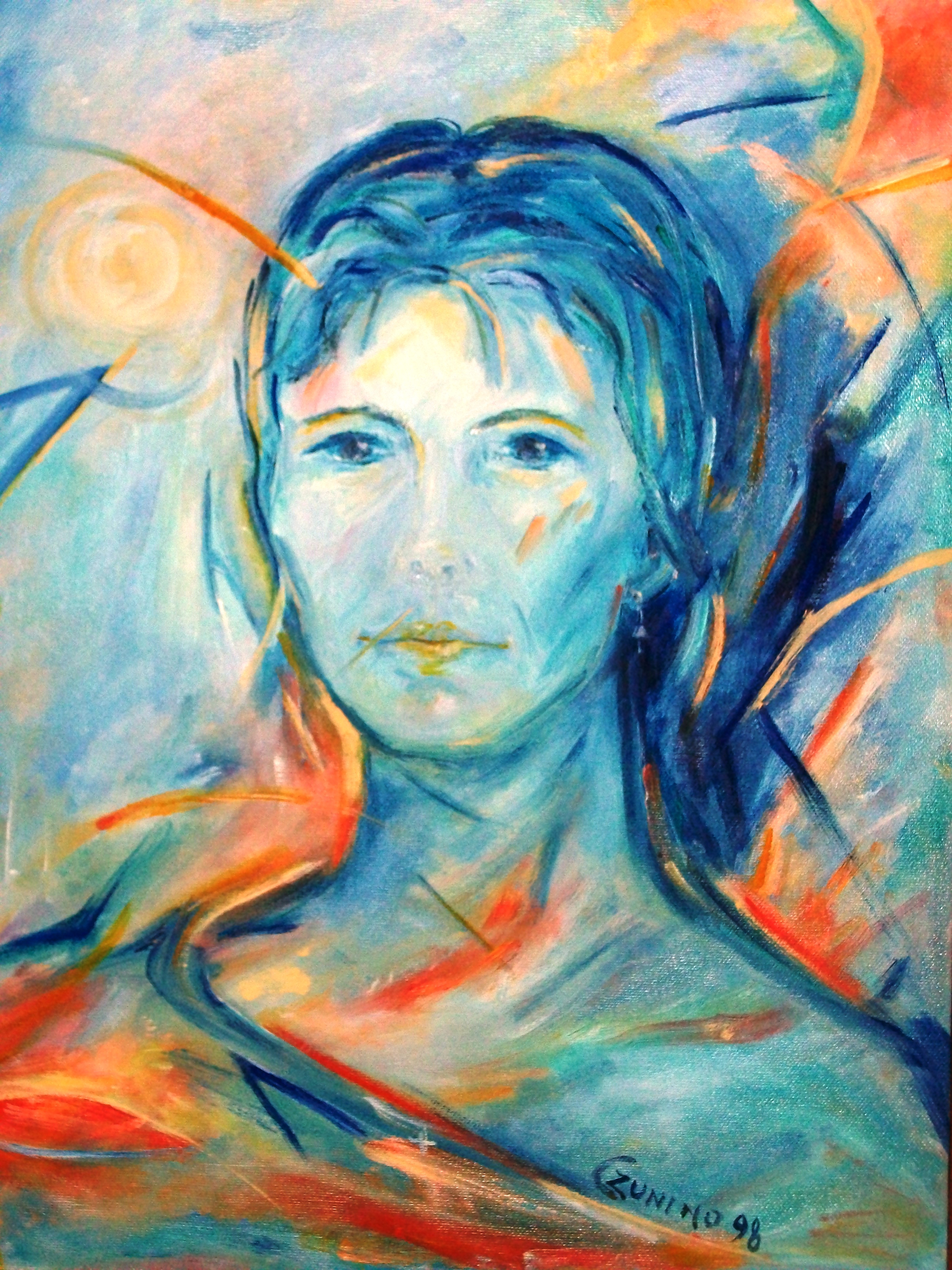Anima
IL tema dell’anima è il tema fondamentale della psicologia, è il tema che fonda la psicologia. Il termine “psicologia”, in senso etimologico, significa discorso sull’anima. La psicologia nel corso della sua storia, inseguendo il sogno illusorio e fuorviante di divenire Scienza, si è data strumenti di indagine e riflessione tipici delle scienze naturali. Così facendo ha dell’anima indagato più la sua forma apparente, lasciando sulla sfondo la vera essenza di essa. L’anima è un’esperienza particole dell’essere umano: è quell’esperienza dell’unicità attraverso la quale sentiamo risuonare dentro di noi un certo evento; in quel caso quell’evento entra dentro di noi e va a costituirsi come la nostra realtà interiore restituendoci il vissuto della soggettività; è un’esperienza che trasformare un evento in significativo per me. Il guardare quel particolare albero diviene esperienza di Anima nell’istante in cui il mio guardare trasforma quell’albero in qualcosa che ha significato per me.
L’esperienza del proprio significato
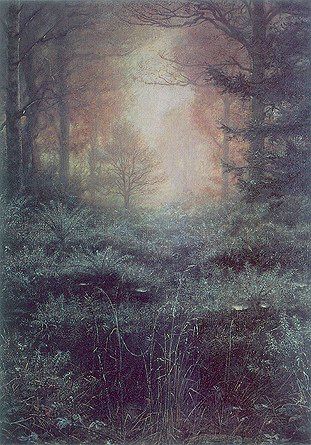
Il soggetto umano nella sua evoluzione percorre due linee direttrici:
1- quella che lo porta a sempre migliori capacità di adattamento;
2- quella che lo conduce a sempre più profonde riflessioni sulla modalità del suo rapportarsi al mondo.
L’evoluzione che porta il soggetto a migliori capacità di adattamento trova il suo riferimento iniziale nelle esigenze fisiologiche. In generale sono le esigenze che si riferiscono agli appetiti della biosfera. In questo ambito d’esperienza il soggetto, per così dire, è guidato dalle condizioni e dalle circostanze ambientali.
La linea direttrice che conduce il soggetto a sempre più profonde riflessioni sul modo di rapportarsi al mondo ha come punto di riferimento un fatto prettamente umano: il valore etico del proprio esserci nel mondo.
Questa esperienza è espressa da domande del tipo: perché esisto? Quale fine giustifica la mia presenza nel mondo? Quale scopo ha la mia azione?
In effetti il passaggio storico dalla condizione animale a quella umana avviene proprio come momento riflessivo circa il valore etico dell’azione esercitata sul mondo. Alle sue origini l’uomo si trova ad essere animale predatore come tanti altri; ma ad un certo punto della sua storia accade qualcosa di inaspettato. Egli, osservando le sue mani lorde del sangue della sua vittima, si trova a domandarsi il perché, il motivo di ciò che ha fatto: il perché del suo uccidere. Domanda questa che scaturisce dall’inquietudine esistenziale tutta umana che è vissuta come compassione e sentimento di pietà verso la vittima. La giustificazione della propria alimentazione, della propria sopravvivenza sul piano fisico-biologico, non è sufficiente a placare l’inquietudine e l’orrore di fronte alla pietà della sofferenza mortale. Qui nascono ritualità che costituiscono il nucleo di molte religioni come il rito dell’uccisione sacrificale dell’animale. In questi riti l’uccisione stessa e l’animale ucciso costituiscono l’offerta a Dio. L’uccisione diventa momento sacro: “sacrificare” e “sacrificio” trovano la loro comune radice etimologica nel termine “sacro” e quindi “rendere sacro” . Il che ci porta a ritenere che l’atto dell’uccisione viene recuperato sul piano di una giustificazione trascendente, quindi recuperato sul piano della giustificazione etica. In questo senso si può dire che l’uomo non può stare senza una giustificazione etica, e si può altresì affermare che l’uomo è un sistema etico. Eticità e umanità sono indissolubili.
E’ evidente che le domande relative ai significati non possono trovare risposta sul piano di una spiegazione meccanicistica del mondo, utilizzando quindi lo schema interpretativo di causa-effetto. Infatti il soggetto non si pone l’interrogativo circa la causa del suo esserci, ma si interroga sul fine, sullo scopo. Il mondo dei fini è il mondo dei significati, quindi dei valori, dove una cosa trova la sua giustificazione in qualcosa che la trascende (in un assoluto che trascendendola la comprende).
Ma cosa vuol dire che una cosa trova la sua giustificazione in qualcosa che la trascende?
Ogni cosa non è finita in se stessa, ogni cosa rimanda ad altro. La lampada, la scrivania, il tavolo, la sedia, tutti gli oggetti che si trovano nella mia stanza non sono finiti in se stessi, rimandano sempre a qualcosa d’altro. La mia matita, per esempio, rimanda allo scrivere che le si pone come trascendente rispetto ad essa: la mia matita trova la sua giustificazione (del suo esserci nel mondo) nel mio scrivere. Lo scrivere, a sua volta, rimanda ai miei pensieri, ma non soltanto a quelli poiché ad essi soggiace la mia esigenza di scrivere, di esprimere e comunicare certi miei contenuti mentali propri della mia esistenza. E tale esigenza, del comunicare, rimanda, a sua volta, al rapporto che io, come soggetto umano, vivo con l’Altro con il quale anelo comunicare.
Da ciò possiamo ricavare due considerazioni:
· la prima è che ogni cosa vive in un rapporto;
· la seconda è che il valore dell’esistenza di una cosa non è mai appreso immediatamente nell’atto percettivo, ma è colto nel trascendimento di questo.
Per trovare il valore esistenziale di una determinata cosa devo dunque individuare il rapporto nel quale quella cosa è situata. Quando si dice che nella nostra società non ci sono più valori ciò non è del tutto esatto. Il fatto è che sono mutate le relazioni nelle quali le cose e le persone sono collocate. Cosicché i valori sembrano scomparsi: ma in effetti ciò che è scomparso è un modo di relazione. Per trovare i valori contemporanei dovremmo indagare e scovare le relazioni in cui le cose e le persone si danno.
Facciamo un esempio.
Nella cultura contadina l’anziano aveva un ruolo e quindi un valore centrale. Ciò era determinato dal rapporto economico che le nuove generazioni avevano nei confronti dell’anziano che solitamente era il proprietario della terra. Il rapporto, in questo caso economico, che intercorreva tra genitore e figlio determinava il valore del padre. Infatti il padre rimandava alla titolarità della proprietà della terra. La proprietà della terra è l’elemento trascendente che individua e valorizza il ruolo sociale e interpersonale agito e incarnato dal padre. Con il mutare delle condizioni economiche e di proprietà, nonché delle modalità di acquisizione della proprietà, la centralità dell’istituto del patriarcato, e quindi del padre, viene meno. Il rapporto è chiaramente mutato. Questo mutamento modifica il valore di quella figura sociale ed affettiva. Risulta quindi mutato il valore affettivo e il valore sociale di quella figura. La morte del patriarca era senza dubbio una tragedia più profonda – sia sul piano sociale che sul piano personale – della morte del padre nella società contemporanea.
Quindi abbiamo osservato che il rapporto quale realtà immanente è colto mediante l’atto del trascendimento, trascendimento che ha come intenzione quella della ricerca del valore, inteso qui come relazione fondamentale.
Il rapportarsi è quindi la modalità che più d’ogni altra sostanzia (da sostanza, realizza, rende concreta, manifesta, rendere visibile) l’esperienza umana, che ha come sua matrice basilare l’anelito alla scoperta del senso, della giustificazione dell’esserci.
Senza un qualche significato della propria esistenza l’uomo non può vivere come uomo. Se l’uomo non ha tra le mani un significato che lo spinge a superare se stesso, sarà indotto a trovare tale significato nell’immediatezza della sua vita, e ciò lo porterà ad enfatizzare gli appetiti istintuali, quelli relativi all’appagamento immediato dei bisogni fisiologici, e quindi sarà preda della legge naturale.
Il bambino nasce in questa condizione, ed è destinato a rimanerci se non trova la possibilità di cogliere il valore etico del proprio rapporto con il mondo. Se egli è preda degli istinti tenderà a vivere il rapporto in modo utilitaristico.
Poiché egli sperimenta prevalentemente una sola legge, il soddisfacimento immediato dei suoi bisogni, questa tenderà a strutturare tutta la sua personalità. In una tale situazione esistenziale al bambino non interessa la crescita del rapporto, ma solo se stesso, un se stesso tutto identificato nei suoi bisogni immediati.
Possiamo osservare, ai fini del nostro discorso, che il bambino instaura rapporti con il mondo delle cose e con il mondo delle persone.
Con il mondo degli oggetti il bambino ha rapporti di tatto, di conoscenza e di funzionalità. Questo è un rapporto finalizzato al loro uso e a soddisfare determinati bisogni, come il piacere per esempio. In questo tipo di relazione il bambino impara a “dominare e usare”. Sono capacità importanti e che lo aiuteranno ad affrontare più adeguatamente la vita.
Il dominare diviene capacità di gestire, di governare certi processi dell’esistenza; l’usare evolve nella capacità del soggetto di poter disporre degli oggetti o situazioni che mano a mano gli si pongono di fronte.
Anche con il mondo delle persone il bambino sviluppa interazioni di conoscenza e funzionalità. Anche in questo caso il bambino impara a dominare e ad usare. Ma qui la situazione esistenziale possiede ben altre potenzialità di sviluppo. Se il rapporto con le cose non riesce ad andare oltre le categorie sopra menzionate – dominio e uso (quindi è una relazione che possiede un potenziale evolutivo limitato)-, la relazione con il mondo delle persone ha notevoli possibilità di sviluppo. Ad esempio non soltanto di crescita conoscitiva, ma bensì di crescita e ampliamento etico, e quindi dell’evoluzione della coscienza quale sperimentazione soggettiva della dimensione storico-universale. Quando parliamo di eticità parliamo di quell’elemento che costituisce l’interfaccia tra la dimensione personale-individuale-particolare e la dimensione collettiva-storica-universale. Difatti le problematiche etiche si collocano proprio nel momento di relazione tra il soggetto in quanto entità singolare e il soggetto in quanto elemento di una totalità sovraorganizzata. E’ evidente che la realtà etica spinge il soggetto a uscire dalle propria dimensione di individuo per aprirsi ad interrogativi sovrapersonali che derivano dalla dimensione storico-universale.
(Se l’oggetto è muto e si piega al volere del soggetto, la persona non si piega e ciò ende il rapporto più problematico)
Quando il bambino interagisce prevalentemente con il mondo degli oggetti e non riesce a scorgere differenza tra questo e il mondo delle persone, tenderà a trasferire le competenze acquisite nel primo modo di rapportarsi al secondo. In altre parole tratterà le persone come fossero oggetti poiché per lui non vi è differenza significativa. Tenderà ad enfatizzare le sue competenze in ambito di dominio e uso. Quanti rapporti umani possiamo definire fermi a questo stadio?
Si rende necessario quindi che il bambino impari a cogliere la pecularietà inerente al rapporto con il mondo delle persone. E la pecularietà è proprio la forte connotazione Etica di tale rapporto: la presenza in esso dell’amore.
Ma l’amore ahime! subisce l’inquinamento delle modalità prevalenti in un individuo: nell’amore infatti noi viviamo la nostra personalità. L’amore risente della immaturità o maturità della personalità; in altre parole risente del livello evolutivo raggiunto dalla persona.
Una personalità abituata a esprimersi in un rapporto di dominio e uso sarà una personalità ferma alla dimensione egoica quindi prevalentemente egoriferita: sarà una persona che non riesce ad uscire da se stessa. Infondo il rapporto con gli oggetti non ci permette di porre il problema “dell’oggetto”: quindi siamo schiacciati al livello delle esigenze immediate dell’Io; mentre il rapporto con una Persona ci obbliga a domandarci “dell’Altro”. Naturalmente questo interrogarsi dell’Altro sarà più coinvolgente se esiste con l’altro un profondo legame d’amore. Ma questo amore deve essere aiutato a svincolarsi dall’inquinamento delle modalità egoiche: dominio e uso.
Da quanto detto si ricava la necessità che il soggetto percepisca se stesso come utile e necessario all’altro del suo amore. Egli deve sperimentare quella dignità soggettiva che lo porta a sentire come di valore la sua presenza nella relazione. Ma come è possibile realizzare una tale forma di rapporto?
Il discorso è complesso basti però ora accennare ad un punto essenziale. Un rapporto è vero e autentico quanto rispetta l’esigenza di ciascuno di trovare se stesso. Quando lascia libero ciascuno di esser ciò che è: ed è questa ricerca di sé che costituisce l’equilibrio su cui poggia l’esigenza ed il valore di quel rapporto.
La solitudine: un’esperienza tra emarginazione e spazio soggettivo

La solitudine, come esperienza, può assumere i connotati dell’emarginazione; ma può anche delinearsi come lo spazio soggettivo nel quale emerge la parola interiore: la realtà interiore dello spirito.
Due modi diversi di vivere la stessa esperienza che risentono, per la loro definizione, del livello di coscienza o meglio della maturazione della personalità.
Infatti una personalità immatura (più avanti spiegheremo cose intendiamo per immatura) tenderà a vivere la condizione di solitudine come l’esperienza dell’emarginazione, cioè percepirà l’assenza dell’Altro come vuoto esistenziale: come incompletezza della propria esistenza.
In una tale esperienza è predominante, nel campo della coscienza, il senso del vuoto inteso come nulla. Un nulla schiacciante che mortifica la persona e ne svilisce il valore soggettivo.
Quest’insieme di vissuti e sentimenti presuppone un significato e un anelito propri dell’essere umano.
Il senso del vuoto, sperimentato di fronte alla mancanza della presenza dell’Altro, rimanda e suppone l’anelito verso l’Altro; rimanda all’essenzialità, per la Persona umana, che l’Altro ci sia, che l’Altro si faccia presenza nel rapporto.
L’Io, diceva Edmund Husserl, ha natura intersoggettiva. Ciò significa che l’IO non c’è, come realtà empirica, se non nel continuo rapportarsi all’Altro. L’anelito al rapportarsi è dunque connaturato all’Io. E’ tanto connaturato da costituire una condizione ontologica: vale a dire una condizione essenziale per l’esserci dell’Io.
Da ciò possiamo ben affermare che se l’Io è impedito o impossibilitato all’esperienza della relazione, il vissuto dell’alienazione è inevitabile. Ciò che viene alienato, sottratto, è l’Io in quanto soggetto. E a ciò consegue la inevitabile mortificazione della Dignità Soggettiva. L’Io fa comunque esperienza della conoscenza, sia pure su un piano puramente e meramente percettivo, ma non fa esperienza della conoscenza come fatto soggettivo in quanto l’esperienza della soggettività è negata.
L’elemento di immaturità, accennato sopra, si colloca proprio in questo punto: l’Io non vive l’esperienza del relazionarsi, oppure, se la vive, ne percepisce la natura condizionante: in altri termini non può essere se stesso.
Nella sua evoluzione un Soggetto umano incontra vari tipi di bisogni la cui soddisfazione è essenziale affinché il cammino continui verso stadi sempre più maturi.
Il bambino viene al mondo portando una serie di bisogni la cui soddisfazione è essenziale per la sua sopravvivenza: basti pensare al bisogno di essere nutrito, protetto dal freddo, ecc. Vi sono poi altri bisogni, come ad esempio l’essere accarezzato o tenuto in braccio, la cui soddisfazione presuppone la presenza dell’Altro. E’ anche attraverso tali momenti che il bambino comincia ad entrare in relazione con l’ambiente umano.
Superata questa fase, e ovviamente soddisfatti questi bisogni primari, il bambino sarà facilitato ad aprirsi verso il mondo che lo circonda. Durante quel periodo egli elabora un atteggiamento positivo verso l’ambiente. Egli sorride alle persone, guarda con interesse qualunque cosa gli venga presentata. Il bambino è pronto a tuffarsi nel mondo umano costituito di relazioni sempre più complesse.
Ed è proprio in questo periodo che il bambino, spinto dall’anelito all’incontro con l’Altro, impara il linguaggio il cui esercizio gli richiede uno sforzo notevole. Ma egli è guidato da un grande anelito d’amore verso il suo prossimo, così fa di tutto per essere accolto e accettato dall’Altro.
E’ qui che emerge il bisogno di appartenenza, di appartenere ad una comunità: qui emergono i bisogni psicologico-relazionali. Qui l’Io manifesta in modo più evidente la sua natura intersoggettiva.
L’esperienza di sentirsi emarginato, di sentirsi escluso è primitiva, è l’altra faccia dell’anelito a stare-con-l’Altro.
Una soggetto che nel corso della vita non abbia superato tale fase, quindi non abbia sperimentato se stesso come interlocutore dell’Altro, tenderà a vivere i momenti di solitudine come momenti di esclusione dagli altri, e quindi a viverli come negazione del proprio Io o negazione del proprio anelito relazionale.
In una fase storica dove il fatto relazionale è scaduto a momento solamente comunicativo e non già di autenticità, l’esperienza della solitudine è molto diffusa.
Nell’infanzia il bambino è lasciato sempre più spesso solo poiché a lui non è richiesto di entrare in rapporto significativo con il mondo degli adulti. Allo stesso tempo le esperienze relazionali tra coetanei sono ridotte tanto più quanto i giochi collettivi vengono meno praticati. Le attività che il bambino svolge sono sempre più individuali, e individualizzanti. I momenti di aggregazione sono ristretti nel tempo e nello spazio.
Nell’organizzazione della famiglia, come nell’organizzazione della scuola (tanto per citare due realtà sociali rilevanti nella vita del bambino), l’accento posto al fatto relazionale va da un massimo di trascurabile ad un minimo di assenza.
Quanto si adopera la scuola per insegnare ai bambini a rapportarsi tra di loro? Quanto li aiuta a comprendere le reciproche differenze?
E la famiglia non ha forse delegato quasi completamente alla scuola l’educazione dei figli, abdicando al ruolo che essa ha sempre svolto di trasmettitore di valori? E così facendo, la famiglia si deresponsabilizza al perfezionamento dei valori umani. Poiché i valori non sono dati nella storia dell’uomo una volta per tutte, ma seguono una loro evoluzione. E chi li fa evolvere se non l’uomo stesso nel corso della sua esistenza? Cosicché l’elaborazione dei valori è sempre più affidata alla struttura economica dominante. Così anche i valori diventano oggetto di consumo, invece di essere momento di elaborazione soggettiva delle realtà relazionali vissuta.
Dove oggi il bambino può recuperare quel senso della relazione umana che sente premere dentro di sé, ma che non riesce a sperimentare in una società che solo a parole si definisce “umanistica”, ma che rivela essere invece prevalentemente tecnocratica, massificante e materialista?
Fin qui la denuncia dei connotati di emarginazione relativi all’esperienza di solitudine.
Colta in questa luce la solitudine sembrerebbe possedere solo aspetti negativi. Ma non è così. In essa sono presenti aspetti interessanti e positivi.
La solitudine è anche lo spazio nel quale può emergere quella parte di ogni singolo soggetto umano che ne costituisce l’aspetto più personale. Alludo ancora una volta alla soggettività.
Quando alle volte il bambino gioca da solo nella sua stanza, dentro di sé egli sperimenta un mondo molto personale, frutto della sua fantasia, della sua capacità creativa di ristrutturare la realtà attraverso i suoi sogni, le sue paure e attraverso i suoi aneliti più profondi e ispirati.
Un bambino in effetti non è mai solo. E’ meglio dire: un bambino che si sente amato, accolto in un mondo pieno di calore, non sperimenterà la solitudine solamente perché fisicamente accanto a sé quel giorno non c’è nessuno: poiché egli avrà imparato a dialogare con se stesso, in se stesso con un se stesso che si fa presenza viva dentro di lui, che si fa presenza interlocutrice dentro di lui.
Chi sperimenta la solitudine la sperimenta sempre, anche quando è in un luogo affollato, poiché non ha imparato a godere della presenza dell’Altro in sé stesso.
Quindi possiamo dire che sperimenterà la solitudine chi non avrà imparato a dialogare, parlare con l’Altro, un altro da sé, un soggetto staccato, diverso da sé stesso. E il dialogo con l’Altro è possibile solo nel caso che si sia superata la fase egocentrica, la fase narcisistica dell’anelito relazionale.
E ciò è possibile solo se il soggetto sarà evoluto ad una fase superiore dell’Amore: dall’Amore Egoriferito, all’Amore Eteroriferito. Da chi pone sé stesso al centro dell’Amore, a chi pone sé stesso come il centro dell’Amore.
E’ la nascita dell’Io Etico.
Il vuoto esistenziale è colmato dal partecipare alla vita di quell’Altro che porta il suo fardello di sofferenza e limitazione, un fardello che suscita speranze nuove. Ciò vuol dire che cogliamo l’Altro, quale significativo per noi, quando in esso intuiamo la presenza di quella frattura interiore che lo rende ai nostri occhi “colui che necessita del nostro amore quale momento di ricomposizione di quella ferita”. Il riconoscimento di quella ferita è possibile solo, però, se trova in noi la eco che la fa significativa ai nostri occhi. Lo strutturarsi di un rapporto significativo con l’Altro aiuta a rompere l’isolamento interiore poiché aiuta il soggetto a cogliersi degno di esserci nella relazione. Quindi la riflessione etica si configura quale superamento della solitudine che a sua volta va intesa come scissione tra l’esperienza della vita e il suo senso che viene sperimentato come inutilità esistenziale.
Antologia

Frammento da “Cosa accade al cielo quando piove” di Renato Barbruni
…Soltanto nelle trame infinite dei pensieri infiniti di Dio può esserci l’instabilità. Ma è l’instabilità di ciò che è infinito, eterno e dunque questa è soltanto il battere delle ciglia che sospende per una frazione di tempo lo sguardo, mentre la mente lo tiene, e l’anima si affida alla memoria di ciò che è stato visto. E’ il destino dell’anima quello di affidarsi, poiché essa vive nella sua sospensione, essa vive sospirando; non tocca e non si esaurisce nelle cose certe, essa è sospesa, sospesa tra le cose attuate e le cose in avvenire. Questo è il tremore dell’amore: chi ama è sospeso tra l’attualità, il compiuto, e le cose in avvenire, ciò che è da compiersi. Illusoriamente chi ama pensa di vivere nell’instabilità e pensa che l’amore sia precario: ma l’amore è eterno. Possiamo sospenderne la percezione, la consapevolezza per qualche istante, ma esso vive nella costanza eterna del pensiero di Dio….
Dall’Enneadi di Plotino:
“Credo perciò che gli antichi saggi, che cercarono di ottenere la presenza degli esseri divini erigendo templi e statue, dimostrarono di aver ben visto nella natura del Tutto; essi intuirono che, pur se quest’anima è docile ovunque, è tanto più facile ottenerne la presenza là dove venga escogitato un ricettacolo acconcio, un luogo particolarmente atto a ricevere una qualche porzione o fase di essa, qualcosa che la riproduca o la rappresenti e che riesca, come uno specchio, ad afferrare un’immagine di essa.”
Il ricettacolo che raccoglie l’anima è l’incontro d’amore; è il luogo spazio temporale dove l‘anima si fa presenza e si personifica nell’esperienza del Noi.
Miguel de Unamuno
“Per avere compassione di tutto, per amare tutto, l’umano e l’extraumano, il vivente e l’inesistente, bisogna sentir tutto dentro di sé, dare a tutto una persona. Poiché l’amore personifica ogni cosa che ama, ogni cosa di cui ha compassione… Si ama soltanto chi ci somiglia… è l’amore stesso quello che ci rivela la nostra somiglianza con loro, l’amore personifica tutto ciò che ama. Ci si innamora di un’idea unicamente personificandola.”
L’esperienza dell’amore si svolge nell’intimo della persona là dove la persona diviene persona, nel senso di una esperienza che ci trasforma personificando ogni atto: ogni atto diviene me.
I bisogni dell’anima o soggettività trascendente
 Un grande psicologo americano, Abrhaam Maslow, in un suo importante lavoro, Motivazione e personalità, elabora una teoria interessante sullo sviluppo della personalità. Egli costruisce il suo ragionamento intorno alla nozione di “gerarchia dei bisogni”.
Un grande psicologo americano, Abrhaam Maslow, in un suo importante lavoro, Motivazione e personalità, elabora una teoria interessante sullo sviluppo della personalità. Egli costruisce il suo ragionamento intorno alla nozione di “gerarchia dei bisogni”.
La personalità, dice l’autore americano, cresce e si sviluppa in seguito alla soddisfazione di determinati bisogni, che liberano la coscienza di altri bisogni più evoluti. Nella prima fase della vita sono prevalenti e più presenti i bisogni della sfera biologica. Nei primi mesi di vita il bambino si può dire che non fa altro che mangiare e dormire.
Sembra quasi che non mostri altri bisogni se non quelli alimentari.
Mano a mano che i mesi passano assistiamo all’emergere di altri bisogni: il bambino si guarda intorno, diviene più curiosa e mostra di gradire il contatto fisico con l’adulto; vuole essere preso in braccio, piange quando lo si rimette nella culla.
A volte sembra che non voglia più abbandonare l’abbraccio della madre.
Già in quella prima fase della vita la madre sente in se stessa naturale parlare al bambino, rendendolo così partecipe delle cose che fa’.
Anche se la madre sa che il bambino non capisce le sue parole, ciò nonostante continua a parlare e così facendo il bambino si sente e vive l’esperienza della relazione.
Oltre all’abbraccio, al sorriso, agli sguardi che il bambino sente rivolti a lui, anche la parola, sia pure incomprensibile, lo conduce nel mondo relazionale ove trae quel senso di appartenenza che costituisce un bisogno tra i più importanti.
L’apparire di questo bisogno, dice Maslow, introduce il bambino nella sfera psicosociale. E’ qui che il soggetto si misura con gli altri, ed è qui che nasce tutta una serie di bisogni che andranno a fondare la problematica relazionale. Proprio nel relazionarsi con l’Altro il soggetto è spinto a rivolgere lo sguardo su di sé alla ricerca del proprio valore relazionale. Ed è qui che la domanda si sposta dal valore nella relazione al valore soggettivo, cioè dal valore di se stesso al di là della relazione.
E’ in questa fase che emerge alla coscienza del soggetto la problematica intrapersonale, vale a dire il rapporto con se stesso. In altre parole si fanno sempre più presenti i primi bisogni dell’anima.
Qui indichiamo solo alcuni di questi bisogni.
Il bisogno di autostima, è uno dei bisogni fondamentali dell’anima in quanto è l’esperienza che porta il soggetto a godere del rispetto di se stesso. L’autostima non va confuso con l’eterostima (la stima da parte degli altri). La stima (o eterostima) è un valore che gli altri ci attribuiscono, l’autostima è il valore che noi stessi ci attribuiamo. In tante crisi di identità è proprio l’autostima che viene a mancare anche quando gli altri sono prodighi di stima nei confronti del soggetto. Quando viene a mancare il rispetto di se stessi la personalità frana.
Un altro bisogno dell’anima è li bisogno all’autorealizzazione. E’ il bisogno di un soggetto di realizzare la propria unicità e irripetibilità. Se un soggetto non può realizzare se stesso vive un sentimento di alienazione che lo porta alla disistima. Questo sentimento negativo è presente in tanti stati d’anima che sfociano nella depressione.
I bisogni etici sviluppano altre dimensioni dell’anima. Fra questi il bisogno di giustizia. Tutti ricorderanno il discorso della montagna: “Beati colore che hanno fame di giustizia, perché verranno saziati.” L’anelito alla giustizia è uno dei bisogni etici che il bambino sente frustrato. Spesso nei suoi confronti l’adulto tende a dimenticare che la giustizia non ha età. Molti bambini vengono soddisfatti nei loro bisogni biologici, sono ben nutriti, protetti da mille pericoli, ma forse non godono di quella giustizia profonda che condurrebbe loro a sperimentare il senso e la dignità della propria presenza come persona nella relazione. Ecco che abbiamo toccato una altro bisogno fondamentale dell’anima: la dignità soggettiva. Forse possiamo anche dire che questo sia il bisogno più importante. In termini mistici è la risposta alla domanda che Sant’Agostino si poneva con grande inquietudine: “Ma chi sono io Signore che mi hai cercato in ogni luogo?” Il che vorrebbe dire: Quale valore ho per te Signore? Il valore che sento di rappresentare è sperimentato con quel sentimento di dignità soggettiva che fa sì che io avverta l’importanza del mio esserci nel mondo, il senso della mia stessa esistenza. Il valore soggettivo è sperimentato a prescindere, e trascendendo tutti i ruoli che il soggetto può interpretare e vivere nel corso della sua vita. Il valore è trovato in quel unico e irripetibile che è l’anima. Diceva Jaspers: “…l’anima è divenire, espansione, differenziazione, nulla di definitivo e di compiuto…”
Una relazione umana deve tenere conto dei bisogni della biosfera, dei bisogni psicosociali e dei bisogni dell’anima. Deve anche tenere conto dei tempi dell’evoluzione del soggetto, dei conflitti che vive il soggetto nella sua realtà relazionale e nel rapporto con se stesso.
La bellezza
 Consideriamo il tema della bellezza partendo dalla parola greca Kosmo. Si riferisce, come è ben noto all’insieme organizzato di pianeti, stelle, galassie e altri corpi celesti che compongo l’interezza del mondo visibile. Anche la parola di origine latina Universo si riferisce alla stesso oggetto.
Consideriamo il tema della bellezza partendo dalla parola greca Kosmo. Si riferisce, come è ben noto all’insieme organizzato di pianeti, stelle, galassie e altri corpi celesti che compongo l’interezza del mondo visibile. Anche la parola di origine latina Universo si riferisce alla stesso oggetto.
Nonostante si riferiscano allo stesso oggetto i due termini lo indicano e quindi lo definiscono attraverso accenti diversi. Il termine greco kosmo tende a significare “ordine opportuno”, “appropriata sistemazione”: cioè organizzazione di un sistema attraverso un principio di armonio e di equilibrio. Elementi questi ultimi che rientrano all’interno della dimensione dell’estetica. D’altra parte il termine cosmesi deriva proprio dalla parola cosmo. Mentre la parole latina Universo significa organizzazione intorno all’uno: uni-verso.
Questo termine quindi indica una aggregato che si organizza intorno ad un centro, seguendo un principio di autorità.Quindi il cosmo, come organizzazione del mondo visibile, trova nel principio estetico una forte componente organizzativa, anche se non l’unica.
Mentre Universo lo trova nel principio di autorità. Ma la parola Kosmo, fa osservare J. Hillman “abbraccia significati come “in maniera conveniente”, “decentemente”, “onorevolmente” (Politica della bellezza, pag,94 J. Hillman, Ed. Moretti e Vitali). Tutto ciò spinge il significato della parole a collocarsi come sintesi tra estetica e morale. Proseguiamo il nostro ragionamento citando ancora Hillman quando riporta le caratteristiche di Afrodite, la dea greca della bellezza.
“…Ma Afrodite era più che una gioia estetica: era una necessità epistemologica, perché senza di lei tutti gli altri Dei sarebbero rimasti nascosti, come le astrazioni della matematica e della teologia, ma mai realtà palpabili.”
Passo suggestivo questo che si riferisce ad una potenzialità portentosa inerente all’esperienza di Psiche quando è toccata da Bellezza-Afrodite. La bellezza ci giuda verso l’intrinseca verità delle cose. Come gli è possibile? Quando siamo affascinati da qualcosa, lì noi troviamo l’energia , la motivazione e, successivamente, il risveglio di una più elevate intelligenza tale per cui la cosa nascosta non è più celata ai nostri occhi. Una teoria filosofica, un modello matematico, una teoria politica, una musica, prima che catturarci razionalmente, ci affascina, ci seduce: armi queste proprie di Afrodite, quando la Dea decide che è giunto il momento per noi di passare dal mondo visibile a quello invisibile degli Dei. L’importanza della bellezza sta tutta qui: è un’esperienza che ci apre a dimensioni dormienti della nostra personalità, e ci fa, per questo, più svegli, e quindi più presenti a noi stessi.